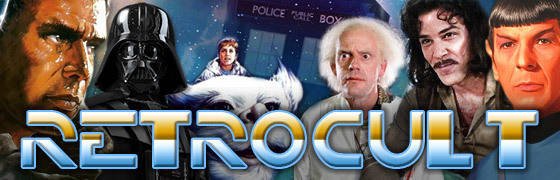Nota del curatore. Quando lessi Universal Robots di Silvia Milani, nel 2015, credevo di avere le idee chiare (errore che, lo ammetto, avrei dovuto superare parecchio tempo fa). Per esempio, credevo di sapere cos'è un robot: una macchina, mi dicevo, con un corpo e una mente più o meno sofisticata.
Con l'articolo di oggi Silvia, che nel frattempo ho avuto il piacere di conoscere, ci ricorda che il Robot è un'idea, un concetto, un pensiero. Oggi il robot è sopratutto software, spesso in cloud. Qualcosa che è intorno a noi, sopra, sotto, alle nostre spalle e tra le nostre mani. Parliamo con essi quasi ogni giorno, sono più concreti che mai. Meno umani perché hanno perso la necessità di un corpo, eppure più simili a noi per la loro capacità di pensare. Più affondati nell'angosciante uncanny valley, e forse per questo più spaventosi perché più difficili da capire.
E sono dunque un oggetto narrativo, letterario o cinematografico, più potente di quanto sia mai stato. È forse curioso, quindi, che il primo simbolo di questa modernità, ancora forse il più incisivo, si trovi in un film di 36 anni fa. Un momento in cui il robot era ancora poco più che un giocattolo per romanzieri e registi; fatte le dovute eccezioni ovviamente, ma di geni come Dick non ce ne sono poi molti. Se nel 1982 ci si innamorava di Rachael per la malinconica bellezza di Sean Young, oggi ce ne innamoriamo per come quell'androide è diventato uno specchio in cui guardarci, nonché un esempio di umanità con cui misurarci. A maggior ragione dopo ciò che abbiamo appreso di lei in Blade Runner 2049.
Valerio Porcu
Silvia Milani
Nasce a Pesaro nel 1978. Si laurea in lettere a Urbino con una tesi intitolata Il Futurismo e la nascita del robotLa differenza tra umano e robot
Nel marzo del 2015 ho pubblicato il mio primo saggio intitolato Universal Robots, la civiltà delle macchine. Per scriverlo mi ero decisa a dare forma stabile a riflessioni sparse qua e là, scaturite dai due decenni di letture, tenute insieme però da una domanda: "che differenza c'è tra l'uomo e il robot?"
Inutile dire che, nonostante il libro sia stato pubblicato, non sono ancora arrivata a rispondermi. Sì, perché dopo aver illustrato i contorni di un personaggio antichissimo come l'automa, crossando dal taoismo di Lieh Tzu alla leggenda del Maharal di Praga, per finire nei vari istituti di meccatronica del mondo, con un bagaglio cibernetico fatto di Norbert Wiener (Introduzione alla cibernetica), Masahiro Mori e Gregory Bateson (Verso un'ecologia della mente); ho capito che venire a capo della questione significava allo stesso tempo tentare di definire quanto ci fosse di umano nel robot e quanto di robotico nell'uomo.
Per me si trattava di esorcizzare la scena di un film che mi aveva terrorizzata da bambina, quella del robot ED 209 di Robocop, in cui un automa somigliante al prototipo di una mitragliatrice con le zampe, aveva massacrato un colletto bianco durante la sua presentazione ad altri colletti bianchi. Una scena a dir poco agghiacciante.
Umani non si nasce, si diventa
Dopo due decenni di riflessioni e un saggio all'attivo, sono riuscita a capire che non verrò mai capo della violenza di certe macchine; uomini o robot che siano, ma lo considero un traguardo. D'altronde anche P.K. Dick, nel suo zibaldone, aveva detto che nell'Universo esistevano cose gelide e crudeli che lui stesso aveva chiamato macchine:
un essere umano privo di capacità empatica e di sentimenti è identico a un androide costruito, intenzionalmente o per errore, senza di essi. [. . .] qualcuno cui non importa della sorte delle creature viventi sue simili: costui ostenta distacco, come uno spettatore, confermando con la sua indifferenza il teorema di John Donne, secondo cui nessun uomo è un'isola, ma in una formulazione leggermente diversa: un'isola morale e mentale non è un uomo.
Ecco, Dick aveva terrore degli automi quanto e più di me, e perciò si era messo a studiali e a raccontarli. Per sua stessa ammissione i mondi cui dava forma nei suoi romanzi erano popolati di robot, meccanismi e simulacri, perché lo spaventavano a morte. Nei romanzi di P.K. Dick, le intelligenze artificiali sono dei mostri, oppure degli dèi, il che è lo stesso.
Durante la stesura del saggio, mi appariva chiaro che l'automa, ancora prima che un corpo artificiale, un capolavoro di arte orologiaia o il personaggio di un romanzo, fosse una qualità, una funzione operativa, un corpo sottile, per così dire, che animava la parte precosciente dell'umano e dell'animale. O del vivente, se vogliamo dirla più in generale.
Perciò, se esisteva un agire automatico dell'essere umano collocato al di fuori della portata della sua coscienza, questo doveva necessariamente rappresentare il suo modo di essere robot, la sua essenza artificiale, il suo non-autentico o più-autentico, la sua metà senza nome. Ad un certo punto mi ero convinta che prima di tutti c'era l'automa e che umani non si nasceva, ma lo si diveniva. E sotto un certo aspetto lo penso ancora.
Le lacrime di Rachael
E poi c'era Rachael. Rachael Rosen, quella di Blade Runner: l'avevo conosciuta con Ridley Scott (Alien, Thelma & Luise, Il Gladiatore) quand'ero una ragazzina, a sedici anni. Rachael era un robot, sì, ma questo robot non era una mitragliatrice con le zampe. Questo robot, al contrario, piangeva e poi si offendeva, diventava orgoglioso, sorrideva, si arrabbiava e alla fine si innamorava. E io non capivo. Se il robot era empatico come un essere umano, perché doveva essere eliminato come gli altri?
Succede a un certo punto che Rachael, convinta di essere umana, comincia a nutrire dei dubbi sulla sua natura e ne chiede conto al protagonista, Deckard, che sa la verità e gliela rivela brutalmente, all'improvviso e senza troppi giri di parole, visto che lei è un robot.
Allora, con gli occhi lucidi la ragazza gli mostra una fotografia che la ritrae da bambina insieme alla madre. Deckard, le risponde che i suoi ricordi sono innesti che la Tyrell, la fabbrica dalla quale proviene, le ha trasferito nel cervello e che quindi non esiste nessuna madre e di conseguenza nessun mondo di affetti: in definitiva lei non esiste nel cuore di nessuno.
Rachael fugge via, sconvolta, ma perché? Perché all'apparir del vero l'androide si mette a piangere? Di che sostanza sono fatte le lacrime di Rachael e che cosa l'addolora davvero? Dopo molto tempo e a modo mio, ho capito che Rachael piange per la perdita di qualcosa di umano, piange della non esistenza del suo mondo, il che tuttavia, in un'ottica kantiana, equivale a dire "del mondo" tout court.
Se non fosse un androide dell'immaginario del nostro tempo, sarebbe un'eroina di Sofocle o la fidanzata di Giacomo Leopardi. Il suo è un dramma che noi umani patiamo come condizione, ma che, al contrario di Rachael, facciamo più fatica a riconoscere: la perdita delle illusioni o, in un'accezione più spicciola, degli autoinganni.
Umano è potersi raccontare, puntellare ciò che si è sui ricordi di ciò che si è vissuto assieme ad altri, poter dire di essere parte di una narrazione corale, la cui forza dimora negli affetti (No man is a island, cfr.); dunque non ha importanza che i nostri puntelli, la valenza dei nostri ricordi, sia effettivamente della forma o del colore che noi le attribuiamo.
Quando l'illusione muore
Finché l'illusione dura ed è confermata dalle persone che la costituiscono, il mondo resta in piedi, e così noi. Ma cosa succede quando queste spariscono, o peggio, ci rendiamo conto che in sostanza non sono mai esistite?
Mettiamo di scoprire sul volto o nell'atteggiamento della persona amata un'espressione mai vista, una frase inaspettata, una violenza nuova, che ce la aliena in modo irrimediabile. Di fare esperienza di quel non ti riconosco più! che ci sconvolge. Sarebbe una forma più estrema dell'esilio dell'immaginario descritta da Roland Barthes nei Frammenti di un discorso amoroso.
In Rachael questo modello è incarnato in modo radicale, perché, nonostante i suoi sentimenti, l'androide è costretta ad accettare dalle parole di Deckard la realtà della non-esistenza delle persone che ama e dalle quali crede di essere amata (ma non lo è), il che equivale a farla cadere dalla poltrona della dirigenza aziendale della sua esistenza, al cesto dei giocattoli del suo creatore. Un demiurgo sadico e crudele che l'essere umano troppo spesso sa impersonare.
Messi su una bilancia di umanità, al netto dell'empatia, Rachael è di sicuro più umana di Deckard. E di tantissimi altri che oggigiorno si dicono "umani".
Retrocult è la rubrica di Tom's Hardware dedicata alla Fantascienza e al Fantastico del passato. C'è un'opera precedente al 2010 che vorresti vedere in questa serie di articoli? Faccelo sapere nei commenti oppure scrivi a retrocult@tomshw.it.
Retrocult torna la settimana prossima!